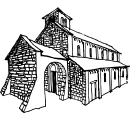
Rinnovamento liturgico e centralità della parola
Oltre Pio V
sintesi della relazione di Andrea GrilloVerbania Pallanza, 19 gennaio 2008
All'interno della riscoperta della centralità della Parola, il ruolo del rinnovamento liturgico oggi merita una particolare attenzione.
Ma, e mi esprimerò subito in modo provocatorio, "centralità della Parola" non significa "centralità delle parole". Certo, significa un rapporto con molte parole autorevoli, un rapporto però che comporta un difficilissimo passaggio di atteggiamento, dal momento didattico della messa alla presenza sacramentale del Signore.
Oggi, pur con tutta la cultura biblica che abbiamo, con l'incomparabile diffusione del testo tra le famiglie dei cristiani-cattolici, abbiamo perso memoria di quanto poco tempo è trascorso, come sottolineava Manicardi in un precedente incontro, da che è consentito a tutti accedere liberamente alla Bibbia. Perfino nei seminari, negli anni precedenti il Concilio, Bibbia e Padri non potevano essere direttamente consultati dai seminaristi e dai giovani monaci, ma solo con avveduto controllo. Questo perché la Bibbia e i Padri non sono ordinati secondo le categorie scolastiche, ma portano disordine, turbamento, minore disciplina, minore possibilità di control-lo.
Bibbia e Padri, però, sono niente rispetto alla liturgia. Se la Bibbia e i Padri sono disordinati, la liturgia lo è molto di più.
Una liturgia strutturalmente trasgressiva
La riscoperta della liturgia nel nostro mondo è possibile solo se rinunciamo ad un certo intellettualismo che ha caratterizzato la Chiesa dal Medioevo in poi, impedendole vieppiù di fare esperienza liturgi-ca. Accogliere questa prospettiva costa molto, perché sembra di per-dere tutto. C'è una minoranza, magari autorevole, che recalcitra, prova paura e persino terrore.
La liturgia è strutturalmente trasgressiva. È trasgressiva per come usa la parola, il canto, le vesti, il profumo. È trasgressiva, perché non è la conferma di una istituzione che già c'è, ma torna continuamente a un fondamento che l'istituzione non può dominare e controllare: il Signore Gesù, presente come luogo di origine di tutto quello che la Chiesa è, come incontro benedicente capace di rendere grazie e di lodare, da cui la Chiesa reimpara l'abc di quello che è.
Nel percorso che faremo, vedremo che nella liturgia la Chiesa non trova tanto il momento espressivo di tutto quello che sa, di tutto quello che vuole, di tutto quello che deve, quanto, piuttosto e prima di tutto, il luogo di origine da cui è donata a se stessa, da cui proven-gono il suo linguaggio, il suo orientamento, persino i suoi valori.
È gravissimo quello che sta succedendo oggi. Si subordina la liturgia ai valori, mentre sono i valori ad essere subordinati alla liturgia. Da qui deriva l'uso "funzionalizzato" delle liturgie, a partire dai valori: si pensano le liturgie a partire dai valori della pace, della vita... È vero il contrario: celebrando i misteri di Cristo scopriamo, straordinariamente dischiuse, queste dimensioni che chiamiamo valori. Il ruolo portante non lo ha il valore, ma il rapporto con Cristo, che nella li-turgia viviamo con un'intimità e un'intensità incomparabile.
Ma chi lo dice oggi questo? La retorica continua a ripetere che la liturgia è il culmine e la fonte, che è culmen et fons. Ma chi, dicendolo intenzionalmente, fa poi quel che dice? Chi davvero comincia dalla liturgia e finisce nella liturgia, perché è consapevole che il meglio che può fare lo riceve da lì e lì lo riporta?
premessa generale
Comincerei con una premessa generale, per farvi capire il taglio del discorso.
Partiamo dal titolo: "Rinnovamento liturgico e centralità della Parola (oltre Pio V)". Ci saranno anche dei riferimenti all' "oltre Pio V", non tanto legati alla contemporaneità, ma al fatto che non è più chiaro oggi (e non solo per il recente motu proprio "Summorum Pontificum") quanto sia diverso il messale di Paolo VI (quello della riforma conciliare) rispetto ai precedenti.
L'ermeneutica del Concilio errata è quella della "assoluta discontinuità", come se la Chiesa fosse nata con il concilio. È quanto affermava Benedetto XVI nel discorso alla curia nel 2005, con cui concordo pienamente. Purché si dica anche, come ha detto il papa (e non come dicono quelli che lo ripetono capovolgendo le carte), che l'ermeneutica dell' "assoluta discontinuità" , non va sostituita con l'ermeneutica della continuità, ma con quella della riforma. L'alternativa non è tra discontinuità-continuità, come tanti ripetono. La logica della riforma dice che la discontinuità è al servizio della continuità. Per poter continuare a celebrare l'Eucarestia la Chiesa ha bisogno di discontinuità, ad esempio nelle forme di partecipazione, nell'unicità del canone romano, nella reintroduzione dell'atto penitenziale... Sono necessari elementi di discontinuità, allorché si fa una riforma. Diversamente la riforma rimane un flatus vocis: si dice che si fa la riforma e si continua come se nulla fosse.
ritornare alle fonti dell'essere chiesa
Vi propongo ora due frasi prese da due ambienti molto diversi.
La prima è tratta dal discorso di apertura di Paolo VI alla seconda sessione del Concilio, il 29 settembre 1963, la prima da lui presieduta come papa, succedendo a Giovanni XXIII. In questo discorso programmatico non solo del Concilio, ma del papato, Paolo VI pronuncia una frase il cui peso specifico molto spesso viene ignorato, e che per me è illuminante per quello che voglio cercare di dirvi.
''"È venuta l'ora, a noi sembra, in cui la verità circa la Chiesa di Cristo deve essere esplorata, ordinata ed espressa, non forse con quelle solenni enunciazioni che si chiamano definizioni dogmatiche, ma con quelle dichiarazioni con le quali la Chiesa con più esplicito ed autorevole magistero dichiara ciò che essa pensa di sé".
Cioè si dice che, senza nulla togliere alla tradizione, che c'è stata, che c'è e che ci sarà sempre, di proposizioni dogmatiche, di proposizioni canoniche di condanna, di proposizioni morali, la Chiesa deve ricominciare dal suo vero punto di partenza. La Chiesa non comincia né come dogma, né come canone, né come proposizione morale. Comincia come ascolto della Parola (Dei Verbum), celebrazione del culto (Sacrosanctum Concilium), relazione testimoniale ecclesiale (Lumen Gentium), rapporto profetico col mondo (Gaudium et Spes)''.
Le quattro costituzioni conciliari non aggiungono mezzo dogma, non condannano nessuno. Questo sarebbe per qualcuno motivo di deprezzamento del concilio in quanto "concilio pastorale", che non ha condannato nessuno e che non ha formulato nessun dogma. Non si capisce che la grandezza del Vaticano II risiede nel fatto che, proprio in quanto pastorale, non vuole essere "meno", ma vuole essere "altro". Vuole ritornare al fondamento, che dà senso ai dogmi, ai canoni, all'esser chiesa. E ci ricorda che i dogmi e i canoni sono al servizio, modesto e umile, del fatto che possiamo leggere il Vangelo di Giovanni, che possiamo celebrare l'eucarestia. E non il contrario. Non si celebra l'eucaristia o si legge il Vangelo di Giovanni per confermare un dogma: è il dogma che è al servizio di una comprensione profonda, di una comunione, del testo scritturistico e del gesto liturgico, nel corso del tempo. Noi abbiamo perduto queste priorità. E il Vaticano II con molta cautela, ma anche con molta decisione, dice che, se non ricuperiamo questo livello, tutto è perduto: ripeteremo i dogmi ad oltranza ma senza esperienza ecclesiale.
La frase di Paolo VI afferma il bisogno di ritrovare un linguaggio più elementare per essere cristiani. Non per smentire il linguaggio dell'astrazione dogmatica, del discernimento canonico, dell'approfondimento nella verità. Tutte queste sono astrazioni benedette, che però non sostituiscono l'esperienza di base. Dogmi, canoni, formulazioni astratte sono necessarie, ma non sufficienti all'esperienza ecclesiale. Questa è la "banalità" che il Vaticano II ha provato a ridire negli anni 60. È una banalità però difficile da capire per chi si era abituato a pensare che la Chiesa potesse vivere soltanto di astrazione. Parallelamente a questo, abbiamo bisogno di uno sforzo teologico, pastorale, ma anche di uno sforzo teorico, senza il quale c'è il rischio che tutti gli sforzi teologici e pastorali cadano nel vuoto.
il linguaggio originario della liturgia
Vi propongo poi, come secondo spunto, una frase del filosofo francese Merleau-Ponty, una frase che non ha niente a che fare con la teologia, ma che ci insegna qualcosa di fondamentale. L'ho tratta da un libretto, che vi consiglio, dal titolo "Conversazioni", contenente la trascrizione di sette lezioni che il filosofo aveva fatto nel 1948 per la radio francese, ritrovate nel 2002 e subito pubblicate e tradotte anche in italiano.
"(con la fenomenologia) impariamo a veder nuovamente il mondo attorno a noi da cui ci eravamo distolti nella convinzione che i nostri sensi non potessero insegnarci nulla di valido e che solo un sapere rigorosamente oggettivo meritasse di essere preso in considerazione... In un mondo così trasformato (in un mondo cioè nel quale si scopre che abbiamo anche i sensi) non siamo soli, e non siamo soltanto tra uomini. Questo mondo si offre anche agli animali, ai bambini, ai primitivi, ai pazzi, che lo abitano a modo loro e che coesistono con esso."
L'esperienza cristiana che facciamo nella liturgia, segnata dalla centralità della Parola, segnata dall'incontro profondo con il Signore, è un'esperienza che non possiamo fare se non ci riconciliamo con la nostra dimensione animale, infantile, primitiva e pazza. Questo dobbiamo ancora quasi impararlo. Il Concilio ce l'ha detto, certo con le proprie parole, e senza citare Merleau-Ponty. Ma ci ha detto appunto che quello liturgico è un linguaggio originario, mentre noi continuiamo a considerarlo un linguaggio secondario. Anche quando lo prendiamo sul serio, lo mettiamo in seconda, terza, quarta, quinta battuta. È difficile mettere la liturgia all'origine, perché la liturgia coinvolge, fa paura, pretende e consola in un modo tale che tiene conto che noi siamo anche animali, bambini, primitivi, pazzi. E lo siamo davvero.
Ognuno deve essere persona adulta. Ma tanto più siamo adulti quanto più siamo riconciliati con la nostra animalità, infantilità, primitività, pazzia. Di questo ha bisogno ogni liturgia della Parola, ogni liturgia eucaristica, ogni rito della comunione.
La liturgia è da noi pensata ancora intellettualisticamente, come se fosse solo il regno dei significati. Ma se fosse così, non ne avremmo bisogno. La novità è che la liturgia è un regno di segni, di riti, ma noi facciamo terribilmente fatica a pensarlo e a viverlo, nonostante la riforma liturgica abbia già trenta-trentacinque anni.
Mentre i cambiamenti sul piano dogmatico, canonico o morale possono avvenire più velocemente, quelli sul piano liturgico hanno bisogno di maggiore tempo, proprio perché hanno a che fare con qualcosa di fondamentale, che pesca nella nostra animalità e infantilità, nella nostra pazzia e primitività. La liturgia cambia davvero solo dopo tre o quattro generazioni.
La riforma tridentina è entrata a regime a metà seicento e, per certi aspetti, alla fine del secolo. Quella del Vaticano II entrerà a regime quando gran parte di noi forse non ci sarà più. È la legge, dura e cruda, della liturgia, che entra a regime quando non c'è più nessuno di quelli che l'hanno progettata e hanno cominciato a viverla. È la logica delle riforme simboliche, che hanno bisogno di tre o quattro passaggi generazionali per assestarsi.
Su questo Sequeri dice una cosa che va ricordata. Il Concilio di Trento è diventato canonico dopo 100-150 anni, e tutti noi lo abbiamo vissuto come una forma canonica. Il Concilio Vaticano II è ancora una forma solo lessicale: ha cambiato le parole, ha cominciato a cambiare gli spazi, i tempi, ma non ha ancora l'autorevolezza canonica del suo predecessore-concilio di Trento. Il fatto che diventi un canone, dipende dalla nostra e dalle prossime due generazioni. Qui si gioca quel piccolo-grande braccio di ferro con chi oggi cerca di fare di tutto perché il Vaticano II non diventi canone. Uno dei modi con cui lo si può fare, nella Chiesa, è di mettergli vicino il canone precedente. Mettendo due forme una accanto all'altra, la più giovane non ce la farà mai a diventare canone. Perché diventi canone ha bisogno di liberarsi dal paternalismo asfissiante del predecessore. Un figlio che ha il padre che gli soffia sempre sul collo, non riesce a diventare adulto. Questo è, in una lettura antropologica, quello che oggi cominciamo a vivere con qualche sospetto.
ricordare e dimenticare
Per tenere insieme la prima e la seconda affermazione, vorrei impostare la mia riflessione secondo quello che dice il sottotitolo: "quattro cose da ricordare e quattro cose da dimenticare".
Se vi sono cose "da non dimenticare", cose che è bene ricordare, e se occorre una conferenza per parlarne, ciò significa che è molto facile non ricordare ed è molto difficile tener viva la memoria.
D'altra parte, il dimenticare non è solo caduta e perdita: è anche virtù e dolcezza. La tradizione ebraico-cristiana benedice l'uomo che dimentica se stesso nel sonno, e anche Gesù poteva dormire, a poppa, mentre la tempesta scuoteva la barca e spaventava i discepoli. La liturgia è uno di questi luoghi dolci, in mezzo alla tempesta, in cui, finalmente, qualcosa può essere dimenticato, perché qualcos'altro possa essere ricordato: riconosciuto nel cuore, rivissuto nel corpo e ripensato nella mente.
Ecco io vorrei cominciare proprio così: se ci sono 4 cose da "non dimenticare" è inevitabile che ve ne siano almeno altrettante che devono essere dimenticate. Noi non siamo hard disk di un computer, che può metter tutto in memoria. Mantenere alcune cose al primo posto nella memoria, non dimenticarle, significa aver ben chiaro che per certe altre cose c'è posto solo dal secondo gradino in giù. D'altra parte, l'uomo è fatto così: ogni qual volta perde una priorità preziosa, guadagna sempre una priorità rischiosa. Perdere una priorità non significa cadere nell'indifferenza: significa lasciare che qualcosa di secondario diventi primario.
Per la mia esperienza di insegnamento della liturgia dei sacramenti, i difetti più gravi non dipendono dal fatto che un sacramento sia dimenticato e un altro sia assolutamente "sprecato", ma dal fatto che non riusciamo a mantenere le proporzioni. Per esempio permettiamo all'eucaristia di diventare assolutamente invadente, pensando che, siccome è il più importante dei sacramenti, possa riempire tutti gli spazi, mentre invece non è così. Anche l'eucaristia, con la sua grande importanza, ha dei limiti, oltre i quali esorbita dalle sue competenze. Così vale per la penitenza, così vale per il matrimonio. Le dimensioni sacramentali vivono di un delicatissimo equilibrio: né troppo poco, ma neanche troppo. Massimizzare un sacramento può essere un modo di sfigurarlo. Ci sono delle priorità false che dobbiamo ridiscutere. Ci sono delle verità dimenticate a cui corrispondono delle evidenze sospette.
1. Orizzonte: Questione liturgica, Movimento liturgico, Riforma liturgica, Forma liturgica della Chiesa
Anzitutto è opportuno presentare un breve profilo storico della liturgia in generale e dell'eucaristia in particolare, così come hanno fatto Manicardi e Noceti per la Scrittura e per l'esperienza della Chiesa.
Prendiamo in considerazione le seguenti quattro parole, alcune delle quali forse vi sono fin troppo note, altre meno: Questione liturgica, Movimento liturgico, Riforma liturgica, Forma liturgica nella Chiesa.
È importante averle in mente in questo ordine, in questa successione.
nascita della questione liturgica
La Questione liturgica nasce in Europa ai primi dell'Ottocento. Nel periodo successivo alla rivoluzione francese, contrassegnato da tentativi di restaurazione, da fughe all'indietro e fughe in avanti, rivoluzioni e restaurazioni, nel mondo liberale che si sta affermando, che scopre le libertà individuali e una certa libertà nei confronti della tradizione, entrano in crisi le forme rituali. I riti non hanno più un territorio di autoconsistenza. Questo avviene nella cultura comune, ma anche nella Chiesa. Nasce in quel periodo la questione liturgica. E questo è, per tutti quelli che riflettono su questi temi, un ottimo antidoto per evitare di dire (come fanno a volte anche alti prelati oggi nella Chiesa) che i problemi nella Chiesa, dal punto di vista liturgico, sono nati nel 1968, causati dalla riforma liturgica, che ha creato confusione in quello che invece era chiaro. Invece la liturgia incomincia a fare problema quasi duecento anni fa!
Già Pio X, ai primi del '900, avendo capito la necessità di cambiamenti, introduce delle innovazioni, che per il suo tempo sono state rivoluzionarie. Abbassa infatti l'età della prima comunione e soprattutto dice che la comunione si può fare tutti i giorni. Prende queste decisioni perché si rende conto che si sta attraversando, siamo ai primi del '900, una grave crisi liturgica. Questo l'avevano già capito molto tempo prima il benedettino Guéranger (1830) e Rosmini (1833-35).
La coscienza che la questione liturgica è aperta fin dai primi decenni del 1800 libera dall'idea che, tornando indietro di 30-40 anni, si risolvano i problemi. Al contrario, si peggiorerebbe la situazione, in quanto ci si ritroverebbe ancora più addentro alla crisi che l'Europa viveva rispetto ai suoi riti.
risposta del Movimento liturgico
Per questo già forse nel 1800, ma ufficialmente agli inizi del 1900, nasce il Movimento liturgico.
a. nella liturgia c'è qualcosa di originario per la fede (1909-1947)
Lasciamo perdere tutti i problemi relativi alle datazioni, che soffrono di campanilismi. Ognuno vuole che le cose nascano a casa propria: il 1909 è l'anno della versione belga, 1903 della versione romana, 1913 della versione francese... Quello che interessa, è che in quel decennio, sotto una certa spinta, indiretta, di Pio X, alcuni uomini, prevalentemente monaci, cominciano a dire che nella liturgia c'è qualche cosa di originario per la fede. La fede trova nella liturgia non semplicemente quello che i medioevali chiamavano protestatio fidei, cioè un luogo in cui esprimere una fede che si ha, ma un luogo in cui comprendere, far tesoro, fare esperienza, di una fede che lì si coglie fino in fondo. E questo è il punto su cui si litiga per 40 anni.
Dal 1909 al 1947, è una continua lite tra Movimento liturgico e professori della Gregoriana, che non sopportavano una lettura del genere, perché mandava a rotoli il loro bel sistemino, che vedeva la liturgia come momento derivato da una serie di obblighi e di regole. Il Movimento liturgico afferma, invece, che il celebrare è originario: è qualche cosa di originario del rivelarsi di Dio e della risposta di fede nel mondo. Dio si rivela e l'uomo crede, in un luogo che è anche originariamente rituale. Senza un rito la rivelazione e la fede sono fragili, deboli, tendenzialmente intellettualistiche. Il Movimento liturgico non nasce a tavolino, da parte di qualcuno che vuole inventare la nuova disciplina della liturgia, ma nasce perché c'è la pressione di un secolo di questione liturgica, nasce come risposta alla questione liturgica.
Il modo di impostare questa risposta per 40 anni resta nella ufficiosa clandestinità. Il Magistero lo fa proprio, in parte, nel 47, sotto Pio XII con la Mediator Dei, un documento bifronte. Frutto di 40 anni di polemiche, l'enciclica cerca di trovare un compromesso, dando un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Infatti, da un lato accoglie molte istanze del Movimento liturgico, tanto da chiamarlo"un passaggio dello Spirito", ma dall'altro ne nega alcune dimensioni fondamentali, salvaguardando anche tutte le pratiche incompatibili con esso. Crea così un doppio regime: quello dei liturgisti o delle parrocchie liturgiste e quello dei devozionalisti e delle parrocchie devozionaliste, che convivono in una parte della Chiesa tra gli anni 40 e gli anni 60.
Per meglio illustrare quanto sto dicendo, vi racconto un episodio accaduto alla madre del monaco Cesare Falletti, priore del Monastero di Pra d' Mill, la quale negli anni '50 viveva per alcuni mesi a Roma e per il resto dell'anno in Alta Savoia. A Roma, dove c'erano parrocchie nelle quali il Movimento liturgico era entrato prepotentemente, questa signora andava a messa tutti i giorni facendo la comunione. Ma, tornata in Savoia, avvicinatasi all'altare al momento della comunione durante una messa, viene rimandata dal prete al suo posto. Al termine della messa, alla sua richiesta di spiegazioni, il prete le dice che quella non era una messa da comunione. E poiché lei protesta, adducendo il fatto che a Roma in tutte le messe si fa la comunione, il prete dell'Alta Savoia le risponde: "Perché a Roma non c'è più religione!" (È una risposta che assomiglia molto a certe risposte che si danno oggi.)
A messa non si dava la comunione nel sistema precedente la Mediator Dei.
Padre Botte nella sua storia del Movimento liturgico pubblicata negli anni 70 (Le Mouvement liturgique, témoignage et souvenirs, Desclée, 1973), racconta che quando lui era ragazzo, agli inizi del 1900, a Parigi, la comunione la si poteva fare prima, durante o dopo la messa, ma mai al momento della comunione. C'era un prete che "diceva messa", e un altro prete che, ogni quarto d'ora, con la stola, andava a prendere la pisside al tabernacolo e distribuiva le particole. Io stesso ricordo che ancora negli anni '60 questo succedeva qualche volta nella mia parrocchia, e l'ho visto ancora accadere a Padova negli anni '80! Veniamo da una prassi secolare, secondo la quale la comunione a messa la fa solo il prete, mentre i laici o prima o dopo. Nei monasteri i monaci, ancora negli anni '30, di domenica, facevano la comunione alle 9 del mattino, andavano a messa alle 11, e adoravano il Santissimo Sacramento dopo pranzo. Si tratta del modello tridentino sancito da un decreto sulla presenza reale, da un decreto sul sacrificio, e da alcune discipline sulla comunione.
Uno dei motivi per cui noi cattolici per 500 anni abbiamo avuto questo comportamento risiede nell'apologetica antiprotestante: dato che i protestanti sostenevano che solo durante la messa c'è la presenza reale di Gesù, i cattolici facevamo la comunione soprattutto prima e dopo.
Al primo posto viene messa non l'esperienza ecclesiale, di fede, nel fare la comunione, ma l'aspetto dogmatico, canonico (apologetico). San Tommaso dice che il primo significato dell'eucarestia non è la presenza reale sotto le specie, ma la comunione nella Chiesa, il vero dono di grazia.
Fino al 47 noi assistiamo ad una grande tensione, ma anche ad una grande elaborazione. Abbiamo dei testi di Odon Casel, di Romano Guardini, di Maurice Festugière che riscoprono davvero che il Signore è presente come Parola, come ministerialità, come assemblea, come preghiera, oltre che essere presente per antonomasia come pane e vino transustanziati.
Da questo punto di vista, come vi ha già detto Manicardi, il numero 7 di Sacrosanctum Concilium (presenza reale di Cristo nella Parola), non solo rappresenta un cambiamento di dottrina, ma invoca un cambiamento di esperienza. E quindi occorre che qualche generazione ne faccia esperienza. Le spiritualità non cambiano a comando, a partire da una certa data! Bisogna che passino diversi anni, anche un secolo, perché quelle parole diventino spiritualità, perché ci si avvicini alla proclamazione e all'ascolto della Parola, in modo simile a quello in cui i nostri nonni si avvicinavano al Santissimo Sacramento. Non basta dirlo: gli stili celebrativi, i portamenti personali, li dobbiamo ancora imparare. Sono affidati alle comunità che in queste cose cominciano a credere davvero e cominciano a fare. Non basta che se li mettano in testa, devono metterseli nel corpo. Devono ritrovarli alimentandosi alla Scrittura, alla tradizione, anche al confronto interconfessionale. Noi oggi siamo più consapevoli che la Chiesa vive la presenza del Signore radunandosi per celebrare compieta, ma a livello pastorale è una risorsa utilizzata in modo infinitesimale! Non c'è bisogno di diventare monaci: bisogna scoprire che la Chiesa che prega il cosiddetto "ufficio" è presenza del Signore, esperienza sacramentale.
b. la riforma liturgica da Pio XII a Giovanni Paolo II ('47-anni 80)
Si passa così ad una seconda fase nella Chiesa: dopo Mediator Dei, le idee del Movimento liturgico vengono sempre più recepite, tuttavia in una sola direzione, quella della riforma. Molto probabilmente era la direzione che inevitabilmente si imponeva. Per affrontare e risolvere la questione liturgica, per recuperare senso al valore "fontale", sorgivo dei riti, si è puntato sulla loro modifica, si è intervenuti su tutta la ritualità cristiana con uno stile che assomiglia molto a quello che aveva fatto il Concilio di Trento 450 anni prima. Lo si è fatto con altre intenzioni, ma con altrettanta generalità. L'intervento del Vaticano II ha riguardato tutti i riti della Chiesa. Tutti i riti vengono riformati, cioè sono portati a una chiarezza rituale, sono ripuliti da incrostazioni lasciate dal tempo, con il ricupero del valore delle esperienze di Parola che il rito fa fare, con l'introduzione di una liturgia della Parola in tutti i riti, con l'uso delle lingue nazionali, che è l'elemento che forse ha colpito di più l'immaginario, al posto dell'unico rito latino.
Questo percorso, che impegna la Chiesa per 40 anni, comincia già negli anni '50 sotto Pio XII e non con il Concilio come alcuni pensano. La vera riforma comincia con il rinnovamento dei riti pasquali e quelli della settimana santa. Si costituisce una commissione che lavora sotto Pio XII e sotto Giovanni XXIII prima del Concilio per poi confluire nei lavori conciliari. In seguito, le cose accelerano, nel senso che si fa una riforma complessiva di tutti i riti, dalla messa al matrimonio, che si conclude negli anni 80, con il rinnovato rito della dedicazione dell'altare e della dedicazione della chiesa.
Occorre però precisare che questo periodo della riforma non è un momento successivo al movimento liturgico, ma ne costituisce la seconda fase.
c. la Formazione liturgica come riscoperta della liturgia come "fons"
Quando negli anni 80 finisce questa seconda fase, il movimento liturgico, almeno nei suoi settori più illuminati, capisce che il compito non è chiuso. E si entra in quel periodo, in cui pienamente siamo immersi, nel quale si capisce che la riforma è stata un passaggio necessario, ma non sufficiente. Fatta la riforma, si rischia di non aver modificato gli atteggiamenti con cui ci rapportiamo ai riti riformati. Il rito di Pio V o quello di Paolo VI sono diversi sulla carta, però, se non si cambia atteggiamento, la differenza lentamente si perde. E si crea fortissima la tendenza a considerare il rito più antico come più autorevole.
Abbiamo difficoltà ad entrare nella terza fase del movimento liturgico, quella in cui bisogna lasciare che i riti riformati diano forma alla Chiesa, in tutti i sensi. Anche nel senso della muratura! Perché se si dice che la forma della Cappella Sistina è la forma della celebrazione, per forza si è costretti a celebrare, magari con i riti nuovi, ma con gli atteggiamenti vecchi. Ma la Cappella Sistina non è il Louvre. Non è semplicemente un museo, ma qualcosa di vivo. E allora ha bisogno di essere adattata. (ndr.: il 13 gennaio il papa ha celebrato la liturgia nella Cappella Sistema sull'altare originario e quindi con le spalle ai fedeli)
Un mio collega, responsabile per molto tempo del settore liturgico, affermava che era stato un errore non aver fatto l'adattamento della Cappella Sistina. Dopo lunghe discussioni era prevalsa l'idea di lasciarla com'è (un'idea tipicamente da sovrintendenza alle belle arti, per cui una cosa antica, per essere ammirata, non deve essere modificata in nulla), cioè un posto dove vengono guidati i turisti a vedere Michelangelo, ma dove, tendenzialmente, non si celebra più. È quello che succede in molte grandi cattedrali del nord, come Gand o Bruges, dove si va a vedere Rubens o Van Eyck, l'adorazione dell'agnello mistico, ecc.. Sono cattedrali ridotte a museo per sei giorni alla settimana, e poi, la domenica, ad una certa ora, sono vietate ai turisti perché c'è la messa.
Questo è l'esito dell'essersi lasciati irretire da un'idea di tradizione modernistica, una tradizione fatta di monumenti, non di vita. Il monumento, in quanto monumento, può restare così com'è per sempre, mentre un edificio vivo si trasforma. La vita fa sì che ci sia un altro altare, mentre quello che è stato usato per 400 o 500 anni diventa irrimediabilmente monumento, qualcosa di grande, ma morto. Dove c'è vita, le generazioni passano anche negli altari e nelle chiese. Rendere tutto contemporaneo, lasciare tutto così com'è, è la logica dei musei, non delle famiglie. È la logica dei centri storici, non delle città.
La liturgia è un ambito estremamente delicato e non la si può costringere in un museo. Si facciano pure i musei diocesani, per mostrare determinati oggetti ed opere d'arte. Le chiese, invece, sono luoghi di vita, e gli interventi di trasformazione, evidentemente fatti con gusto e sensibilità, sono necessari. Dove cambiano i paradigmi, o si vive trasformando oppure si crede di vivere, ma in realtà si visita un museo.
Allora, nella terza fase del movimento liturgico, lasciare che la liturgia dia forma alla chiesa significa darle la parola a tutti i livelli: a livello dei muri, come abbiamo visto, ma anche del tempo, delle sensibilità, dei gesti, delle parole...
la tensione tra tre concetti di "forma" e di "ministro"
Tutto questo comporta una importante novità di carattere teorico. Infatti, noi usiamo, per parlare della liturgia, soprattutto per i sacramenti, una terminologia classica, di almeno 800 anni, che individua i sacramenti nella intersezione tra tre dimensioni: forma, materia, ministro.
Per molti secoli abbiamo pensato la forma come una formula (la formula di consacrazione), la materia come una materia in senso stretto (pane e vino) e il ministro come l'unico competente a dire la formula sulla materia. È una semplificazione scolastica di grande pregio, ma anche estremamente pericolosa, perché riduce ai minimi termini l'esperienza sacramentale nel mettere insieme formula, materia, ministro unico.
La riscoperta della centralità della Parola (la Parola con la P maiuscola!), il prendere sul serio le parole dell'eucarestia, come di tutti i sacramenti, ha comportato un primo, fondamentale cambiamento di paradigma, un ripensare tutta la forma verbale. La forma dell'eucarestia sono tutte le parole che si dicono, la materia è certamente il pane e il vino, ma dentro una serie di relazioni. È un pane preso, mangiato, dato, dunque non fermo, ma in movimento. È pane e vino non in senso stretto, materiale, immediato, ma pane e vino considerati nel loro significato storico. Questo comporta, come terza conseguenza (che è forse la più importante), che con questa forma verbale ampia, con questo concetto di materia storica, la ministerialità diventa plurale.
Se noi osserviamo il rito dell'eucarestia, vediamo che sia le tante parole, sia il movimento del pane e del vino durante la celebrazione non hanno un solo soggetto, ma molti: qualcuno presenta i doni, qualcun altro li riceve, in seguito quei doni sono offerti e si ricevono a loro volta come doni, secondo una circolarità che comporta una serie di ministerialità. Oltre quella del ministro che pronuncia le parole di consacrazione, c'è una pluralità ministeriale strutturale. Sono le conseguenze del considerare come forma dell'eucaristia non solo la formula, ma tutte le parole che si dicono, la forma verbale.
Ma non basta. Il movimento liturgico, nel fare la riforma, porta alla luce il fatto che la forma rituale non comprende solo tutte le parole che si dicono, ma tutti i linguaggi che si usano. Nel rito, oltre quello verbale, si usano molti altri linguaggi come quello dello spazio, del tempo, della vicinanza, del colore, del profumo, della musica, del canto, del silenzio, dello sguardo, del tatto, dell'olfatto.
La forma dell'eucarestia è la forma rituale dell'eucarestia. La ricchezza di una forma rituale è quella in cui è coinvolta la nostra dimensione animale, infantile, primitiva e pazza, oltre che adulta. Non c'è semplicemente una formula, su una materia, con un ministro. Il rito non si riduce a questo schema scheletrico, ma si presenta nella sua sovrabbondanza.
La forma rituale dell'eucaristia, insieme alla materia simbolica, ci dice, come fa Agostino, che il pane è frutto di tanti semi di grano, che poi vengono triturati, ci dice pluralità unificata. E di fronte ad una forma rituale, con una materia simbolica, la ministerialità diventa una sola presidenza che coordina tante ministerialità, al servizio dell'assemblea. Insieme a chi presiede, ci sono gli altri ministri: uno che proclama la Parola della Bibbia, un altro che porta i doni, uno che suona l'organo, uno che canta, uno che fa accoglienza, uno che distribuisce la comunione... Queste varie ministerialità sono ministerialità dell'eucarestia, coordinate dalla presidenza, al servizio di Cristo e della Chiesa. I soggetti dell'Eucarestia sono Cristo e la Chiesa, gli altri sono servi, dal papa in giù, di Cristo e della Chiesa. Questo è quanto dice il rito di Paolo VI. Ma noi, quale esperienza facciamo?
2. Quattro cose da non dimenticare / quattro cose da dimenticare
Vi sono quattro cose da ricordare, e altrettante da dimenticare. Ad alcune di queste cose ho già accennato qua e là, ma ora ve le ripresento in maniera più ordinata. Si tratta di quattro dimensioni che, soprattutto nell'aspetto da dimenticare, sentirete forse un po' indigeste. Alcuni di voi potrebbero pensare che, in fondo, sono aspetti in cui ci si trova tanto bene! È un limite della nostra condizione: non riuscire a "dimenticare", a superare, ci impedisce di fare il salto di qualità.
Vi sono quattro cose da ricordare, e altrettante da dimenticare. Ad alcune di queste cose ho già accennato qua e là, ma ora ve le ripresento in maniera più ordinata. Si tratta di quattro dimensioni che, soprattutto nell'aspetto da dimenticare, sentirete forse un po' indigeste. Alcuni di voi potrebbero pensare che, in fondo, sono aspetti in cui ci si trova tanto bene! È un limite della nostra condizione: non riuscire a "dimenticare", a superare, ci impedisce di fare il salto di qualità.
La liturgia, in quanto esperienza comunitaria, non solo non è esperienza privata (essere soli con se stessi di fronte al buon Dio), ma neppure è esperienza pubblica (essere sotto l'occhio neutro del pubblico). Dopo aver combattuto a lungo l'idea di privatezza, facilmente oggi scivoliamo sul versante pubblico, il che è un'altra cattività. È la cattività di chi non capisce più che, per l'eucarestia, per il battesimo, per la liturgia delle ore, ecc., c'è un livello di iniziazione insuperabile. Un sacramento non sarà mai un fatto semplicemente pubblico, ma sarà sempre un fatto comunitario. Per questo ripugna al sacramento una forma pubblica di celebrazione: in uno stadio è insopportabile e in televisione ancor di più. I luoghi pubblici come tali non riescono a garantire quel minimo di separatezza (non nel senso di impedire l'accesso) necessario ad un linguaggio, che, per quanto poco lo vogliamo ammettere, resta un linguaggio iniziatico. Il linguaggio liturgico non è linguaggio comune, anche se attinge continuamente dal linguaggio comune.
Ricordare che l'esperienza comunitaria è diversa dall'esperienza privata, ma anche dall'esperienza pubblica, ha importanti conseguenze in termini di annuncio di valori. Si pensi alla pretesa che il discorso ecclesiale possa immediatamente essere discorso pubblico. Può diventarlo solo con le mediazioni dello studio teologico, dell'impegno politico, ecc.. Sono aspetti che a volte alcuni vescovi ritengono superflui rifacendosi ad un modello di cristianità dove vescovo e capo politico sono la stessa persona. Ma ormai abbiamo acquisito che c'è una differenza, una differenza non solo imposta dal liberalismo, ma accolta anche dalla Chiesa a volte favorevolmente. Per esempio, i vescovi sono stati d'accordo con lo stato quando sono state soppresse le facoltà teologiche statali. Lo Stato lo faceva perché voleva escludere la teologia dallo studio pubblico, e i vescovi perché temevano che, se fosse stato uno studio pubblico, ne avrebbero perso il controllo.
Quindi, sullo studio della teologia, c'è questa ipersensibilità, mentre su cose più delicate come i sacramenti molto facilmente si scivola sul versante pubblico
La liturgia è un tempo festivo
Terza dimensione: la liturgia è un tempo festivo. Anche questa sembra una banalità. Ma, se neghiamo che la liturgia sia tempo libero e tempo del lavoro, capiamo che la liturgia è in grado di farci fare un'esperienza del tempo diversa da quella comune. Il mondo tradizionale conosceva bene il tempo della festa, mentre il mondo post-tradizionale, cioè il mondo liberale, industriale, delle tecnologie avanzate, divide il tempo in lavoro e non-lavoro. In questi due tipi di tempo la messa, il battesimo, il matrimonio sacramentale, l'ordinazione, ecc. non trovano una collocazione. Per celebrare un sacramento bisogna far l'esperienza di un tempo diverso, un tempo che ha come specifico il dono del tempo.
C'è un tempo che ha come specifico il produrre, il guadagnarsi il pane, l'essere utile al prossimo: è il tempo del lavoro. C'è poi un tempo che non si propone nulla, che dice, come il vecchio motto degli orologi Swatch: "fai di me quello che vuoi". È il manifesto del tempo libero, che ci rende sicuramente depressi nel giro di qualche anno, perché abbiamo sempre la responsabilità del nostro tempo.
La festa ci dice che il tempo ci è dato perché lo si usi per servire, e ci è dato con un'esperienza gratuita da parte di Dio e del prossimo. Il tempo festivo dice che se io posso godere del tempo è perché qualcun altro ha perso tempo con me. Possiamo gustare il tempo grazie al fatto che Dio e il prossimo, Dio mediato dal prossimo, padre, madre, fratelli, ecc. ci sono stati accanto perdendo tempo per noi. Abbiamo capito che c'era qualcosa che valeva la pena ricordare e qualcosa che potevamo sperare. L'aspettazione e il ricordo aprono al bambino il tempo.
La Chiesa rompe il tempo libero e il tempo del lavoro, introducendo un tempo festivo. Ma bisogna che sia festa! La festa non è l'aggiunta, ma è la struttura di ogni sacramento, della liturgia delle ore... Per questo normalmente si canta. Si canta perché è festa. È il canto che dimostra che è festa. Invece noi dobbiamo convincerci: "deve" essere festa, allora bisogna anche cantare, e cantiamo come se fossimo tutti in ufficio!
Il tempo festivo ci apre ad un'altra esperienza, all'esperienza di tutto ciò che ci gratifica davvero, senza avere un risultato immediato e senza un nostro controllo. Le feste importanti ci cadono addosso come dei massi. Il compleanno, il Natale... arrivano quando vogliono loro. È la logica della festa, che ci dischiude il tempo gratuito, che non possiamo né programmare né far derivare dal nostro merito e impegno.
Qualche anno fa la televisione trasmette un'intervista ad una signora, che aveva subito un furto. Le avevano malmenato il marito e le avevano portato via tutto: miliardi, diamanti, contanti, collane, oggetti d'oro... Ad un certo punto, la signora dice: "Proprio a noi, che da 25 anni non facevamo un giorno di festa!" Con tutto il rispetto per la vicenda umana, se si vivono 25 anni senza un giorno di festa, come dice il Vangelo, passerà qualcuno e ci ruberà tutto! Con quel comportamento si creano le condizioni perché la giustizia sia infranta. Se non si riesce a donare gratuitamente quello che si ha, verrà qualcun altro a far festa! È sapienza popolare, ma anche evangelica. Nella tradizione ebraica, di sabato non si produce per poter gustare il dono di grazia da parte di Dio.
La liturgia è fons et culmen
Quarta dimensione: la liturgia è fons et culmen, fonte e culmine, sorgente e vetta di tutta l'azione della Chiesa. Questo significa che non è un medium, che non è qualcosa che si può rendere uno "strumento per", una "funzione di". Non si può usare la liturgia per far passare idee, nozioni, o altro. Bisogna superare la logica funzionalistica nei confronti della messa, e in generale di tutte le celebrazioni, fosse anche quella di fare una bella lezione di esegesi sul Vangelo. Stiamo sotto la logica dell'eucarestia che fontalmente, in modo sorgivo, ci dice i significati. Quando diciamo fons affermiamo che tutti gli atti liturgici, e l'eucarestia in particolare, sono fontane culminanti, non un mezzo nelle mani del prete o del laico per far passare qualche messaggio, o qualche informazione.
Nella celebrazione eucaristica il messaggio c'è già, ed è una delicatissima struttura di parola, gesto, incontro, relazione, comunicazione, che nell'omelia può essere in qualche modo variata. Si possono fare delle variazioni illustrative, di approfondimento, spirituali, etiche, ma su quel tema, non imponendo un tema estraneo alla celebrazione, come molto spesso si continua a fare.
Per concludere vi propongo una bella frase di Bonaccorso, che a questo proposito dice: "Noi normalmente nella liturgia pensiamo di dover far passare dieci messaggi più o meno solo con un registro, con un codice, quello verbale, della parola. In realtà, l'eucarestia e la liturgia pretendono che tu dica una sola cosa con 10 codici."
Si dice la stessa cosa con le parole, con il movimento, con il profumo, con la luce, con lo sguardo, con la musica, con i colori: questa è la logica della liturgia. Che è in fondo la logica di tutte le feste. La centralità della Parola significa riconoscere i limiti delle nostre parole. Usarle, valorizzarle, ma in contesti simbolico-rituali.
3. Conseguenze di queste affermazioni e negazioni (nel corpo)
Le conseguenze delle cose dette sono conseguenze "nel corpo". Cosa c'entra il corpo in un discorso teologico?
Per celebrare bisogna accettare, come dice S. Tommaso, che "il fondamento di ogni senso è il tatto". Il tatto è la prima virtù di ogni celebrazione. Provate a fare memoria di quanto tatto avete percepito in una celebrazione in cui le due persone più vicine in chiesa, come succede a volte, sono a 15 metri l'una dall'altra. Il tatto lì percepisce che c'è qualcosa di strutturale che non funziona, in dissonanza con il fare comunità, con il vivere il discepolato di Cristo. Il magistero del tatto occupa il primo posto nella liturgia, a lui deve essere data la prima parola. Invece normalmente l'ordine di importanza è capovolto. Ci preoccupiamo di pronunciare le parole corrette, di compiere i gesti previsti e poi, solo se c'è tempo, pensiamo al tatto. Se non c'è tempo la messa vale lo stesso, secondo categorie giuridiche. Non voglio sostenere che non conti anche l'intelletto o la volontà, ma che le conseguenze vanno valutate anzitutto nel corpo, che è il livello più importante di percezione dei segni.
a. tutti partecipano ad un'unica azione di Cristo e della Chiesa
Se la liturgia è un'azione rituale - riprendiamo i quattro punti e vediamo le conseguenze - tutti partecipano a un'unica azione di Cristo e della Chiesa.
Questo vuol dire che i veri soggetti non sono titolari di diritti e di doveri ma destinatari di azioni, parole, canti, silenzi, avvicinamenti, allontanamenti. Si pensi cosa vuol dire spostare l'attenzione in questo modo. Se è un'azione rituale tutte le logiche puramente oggettive e soggettive restano sullo sfondo e viene in primo piano una logica intersoggettiva.
Mi spiego con un esempio, quello del "fare la comunione". Per un cattolico romano, da secoli, fare la comunione significa ricevere la particola. E questo ancora oggi, sebbene il concilio non secondariamente dica che una novità della partecipazione attiva è la comunione sotto le due specie. Il concilio, nella costituzione Sacrosanctum concilium che è del 1963, parla il linguaggio migliore del suo tempo e nel migliore linguaggio del suo tempo fare la comunione al pane e al calice si dice con un linguaggio dogmatico sub utraque, sotto le due specie, nella specie del pane e nella specie del vino.
Per il corpo, questo linguaggio non è sufficiente. "Comunicare sotto le due specie" è una pessima dizione, perché rispetto all'atto che viene compiuto non dice nulla, semmai rinvia a teorie teologiche. Comunicare sotto le due specie significa partecipare insieme al pane spezzato e al calice condiviso. Questa è la traduzione corporea del gesto, rispetto a cui l'intelletto può lavorare meglio. Se si dice "comunione sotto le due specie" l'intelletto è rinviato al rapporto tra specie del pane e del calice/vino e sostanza del corpo e del sangue di Cristo: è pane, ma è corpo di Cristo; è vino, ma è sangue di Cristo. In realtà sia l'uno che l'altro sono sia sangue che corpo, ma tutta questa logica dogmatica non è sufficiente a farci compiere l'atto liturgico in modo giusto. Infatti, pur con tutta la conoscenza dogmatica, posso ancora oggi vedere che chi presiede spezza il pane e se lo mangia integralmente, mentre tutta l'assemblea si comunica con la riserva. Dogmaticamente non c'è alcun problema, ma liturgicamente è un disastro. Il corpo vede che c'è un banchetto, che c'è il pane che viene spezzato per nutrire l'assemblea e contraddittoriamente vede che chi lo spezza non lo condivide, ma se lo mangia tutto da solo. Sono solo finezze di liturgisti? Si dirà che quello che conta è la presenza reale, la presenza reale sull'altare, la presenza reale nel tabernacolo, ma si tratta di un ragionamento astratto. Quel ragionamento astratto, che non viene smentito, deve stare nella concretezza del gesto, del gesto dello spezzare il pane e del condividerlo tra tutti, dando a ognuno un frammento.
Notate le finezze mistificanti. Chiamiamo particola un pezzo di pane tondo e già diviso, che non ha nulla del frammento. Chiamiamo particola, che vuol dire particella, piccola parte, ciò che in realtà è un piccolo intero. La forma dell'eucaristia che noi usiamo dice individualismo di partecipazione: ognuno ha tutto.
Chi presiede poi deve vincere il pudore di mostrare il frammento. Una volta sembravano tutti dei prestigiatori nello spezzare il pane e nel ricomporlo intero per evitare che si vedesse la frammentazione. Invece è proprio la frammentarietà che deve essere vista per cogliere che è proprio in quella frammentarietà che la potenza dello Spirito crea comunione.
Mangiare tutti lo stesso pane non ci pone problemi. Invece bere tutti allo stesso calice... Anche nel caso di concelebranti in senso tecnico uno beve e due intingono. Significa che la logica sanitaria è più importante della logica della salvezza. Pur non sottostimando l'aspetto sanitario, il problema di un eventuale contagio conta più del contatto? Il gesto familiare del condividere il pane e il vino è un gesto familiare che dice fraternità e figliolanza. Quel gesto dice nel modo più semplice che siamo fratelli, figli di un unico Padre.
Questa esperienza di comunione viene spesso contraddetta nella liturgia della Parola, allorché invece di ascoltare uno che proclama la Parola, ciascuno se la legge per proprio conto sul foglietto appositamente distribuito. E' molto facile che, se le persone che formano l'assemblea hanno il foglietto in mano, uno proclama la Parola, ma in modo finto, perché ognuno se la legge individualmente. Proclamare comporta il pendere dalle labbra di chi annuncia. E questa esperienza fa fare comunione. Se controllo quanto viene proclamato, non ascolto, ma leggo. La presenza è nell'ascolto comune della parola proclamata: è lì che presenza della Parola diventa presenza della comunità. Fa fare esperienza di comunità la parola proclamata e ascoltata, così come condividere un unico pane spezzato e un unico calice fa fare quell'esperienza antropologica di fraternità scandalosa a chi non è della stessa famiglia "naturale", ma si sente parte della stessa famiglia ecclesiale. Sono gesti che rompono con le schiavitù pubbliche e private e fanno entrare in logiche comunitarie. Ma bisogna accettare di farli.
In Belgio, nelle chiese che ho conosciuto e frequentato, è normale che al momento della comunione si crei la doppia processione al pane e al calice. I belgi antropologicamente non sono diversi da noi. Si può imparare a farlo. E anche in Italia ci sono zone in cui si fa, però in fondo permane l'idea che sia un'inutile complicazione. Invece il gesto del condividere pane e calice è un gesto che, nella sua elementarietà, pesca nella animalità, nella sensibilità infantile, nella sensibilità primitiva e un po' anche nella follia. Bisogna essere un po' matti secondo le regole della buona educazione e della buona igiene per fare una cosa del genere. Ma senza un po' di pazzia la fede è sempre un soprammobile
b. né in pubblico né in privato di fronte a Dio e agli altri
Secondo aspetto. Che nella messa non si sia né in pubblico, né in privato, lo possiamo dire in tanti modi. Ma anzitutto lo diciamo perché non ci sentiamo né a un tu per tu con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito Santo né in pubblico di fronte agli altri. Questo comporta un cambiamento nella catechesi. Nella catechesi classica si diceva che "fare la prima comunione", utilizzando l'espressione di Pio X, significa avere un rapporto a tu per tu con Gesù. Si rischia cioè di far passare l'idea che a un certo punto si acquisisce un rapporto più personale e diretto con Gesù, trascurando la dimensione comunitaria, ecclesiale propria dell'entrare in comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Nella celebrazione eucaristica non si è in privato di fronte a Dio né in pubblico di fronte agli altri, ma ci si riconosce riconosciuti, sotto lo sguardo accogliente e nello sguardo riconoscente del Padre e dei fratelli.
Per questo anche il luogo svolge un grande magistero. Costruire il luogo di culto né privato né pubblico nel quale si fa questa esperienza, mette alla prova il committente, l'architetto, il consulente.
La chiesa di San Giovanni Rotondo dedicata a padre Pio di Pietralcina, progettata da Renzo Piano con la consulenza di Crispino, ha una straordinaria area eucaristica, ma è priva di una cappella della riconciliazione, proprio lì dove avvengono tantissime celebrazioni penitenziali. Hanno dovuto recuperare un'aula ampia, ma dal soffitto basso e opprimente, con 43 porte cieche con la spia verde e rossa, senza un orientamento. Fare l'esperienza della penitenza vuol dire anche lasciarsi dire qualcosa di originario dal luogo in cui la si celebra. Se manca il livello intersoggettivo manca l'elemento originario dell'atto che si fa, per cui l'atto è tutto spostato sul privato (è affar tuo che ti confessi) e sul pubblico (devo garantire alcune norme). Formalmente va tutto bene, sia sul piano oggettivo delle norme, sia sul piano soggettivo, ma l'atto può essere un atto mancato liturgicamente, nel senso che quella esperienza che faccio in quel luogo è quella di un hangar, di una sala di attesa di aeroporto, di un obitorio, ma non di una cappella, dove si prega e si incontra il Signore.
La liturgia pesca in un livello intersoggettivo, il più elementare, rispetto a cui noi abbiamo bisogno di astrazioni soggettive e oggettive. Abbiamo bisogno di un'esperienza disciplinare dogmatica dell'eucaristia, che dica quanto è necessario fare per garantire la validità. Dobbiamo poi avere un'esperienza soggettiva, che ci consenta di trovare alimento spirituale, significati profondi. Tra questi due elementi ci possono essere contraddizioni: possono esserci celebrazioni formalmente inattaccabili che non mi dicono niente o posso sentire tutto un mare di sentimenti di fronte a celebrazioni invalide. La liturgia, però, in prima istanza, non bada né all'uno, né all'altro. Prima di tutto istituisce il rapporto tra Cristo e la Chiesa secondo una pluralità di codici che devono essere integrati e rispetto a cui il libro rituale è il canovaccio che non dice tutto, ma è un testo che ha bisogno di un contesto coerente. Le rubriche nel testo mi dicono ad esempio che devo allargare le braccia, ma non mi dicono il modo in cui farlo. Le posso allargare come un manichino e in questo caso seguo il testo, ma non sono nel contesto. Il contesto dice che le braccia larghe indicano che io parlo, ma che in me parla anche l'assemblea, che io parlo, ma che annuncio una parola più grande della mia. Il gesto media questa dimensione. Tutto il non verbale presente nei rituali è altrettanto importante quanto il verbale. Questo lo capisco se parto dal bisogno di un'esperienza comunitaria intersoggettiva, né solo soggettiva, privata, né solo oggettiva, pubblica. Per questo è necessario un cammino di formazione.
c. un tempo reversibile e disomogeneo
Un terzo aspetto riguarda il tempo. A Pozzuoli, in una bella chiesa moderna un prete mi porta all'altare e voltandosi in direzione del fondo dice: "vede, c'è un orologio sopra l'entrata, così quando faccio la predica so sempre quando devo finire." E' disarmante, perché sta a significare che il tempo rituale è scandito dal tempo dell'orologio. Gli orologi contengono tutto, tranne la festa. Il tempo dell'orologio è omogeneo e irreversibile. La festa è fatta di tempo reversibile e disomogeneo. E' una benedizione avere l'orologio al polso, ma poi può diventare una maledizione, quando non riesco mai a prescindere dal suo tempo irreversibile e omogeneo. Il tempo del rito è un tempo non tutto uguale e che non va non solo in una direzione ma anche nella direzione opposta, riempiendosi di differenze.
Il nome di orologio venne impiegato in oriente per indicare il libro rituale. Mentre "calendario" è l'indice romano delle feste, cioè comunica la differenza dei giorni. Non è l'agenda che indica "le cose da fare", ma il calendario mi segnala come il tempo mi dona spazi di novità.
In questa logica bisognerebbe ripensare la delicatezza del terzo comandamento, un comandamento sulla festa. E' il ponte tra la prima tavola che riguarda il rapporto con Dio e la seconda che riguarda il rapporto con il prossimo, ad iniziare dai genitori. A cavallo tra le due tavole c'è: "ricordati del tempo di festa". E' già molto facile non rispettare il comandamento nei confronti dei genitori, quando sembrano superflui, quando si attenuano le loro abilità e capacità. C'è il rischio dell'oblio. Ma se è possibile dimenticare i genitori di cui ho avuto esperienza diretta per 50 anni, quanto più è a rischio di oblio il Dio liberatore dalla terra di schiavitù di cui hanno avuto esperienza i padri, un'esperienza tramandata attraverso il tempo. E' facile cadere nella tentazione di dire: "ma figurati un po' se ho bisogno di lui per essere libero!". C'è la possibilità di rendere il tempo solo esperienza mia, dimenticandomi che nel tempo c'è l'altro-Dio e c'è l'altro-prossimo. La mia coscienza del tempo dipende da come Dio e il prossimo si sono presi cura di me. E' un grande mistero che il rapporto con Dio e con il prossimo sia mediato dal mio rapporto con il tempo. Per cui il tempo della assoluta presunzione (ne faccio quello che voglio), o della assoluta disperazione (corro verso la morte) è segnato dal dimenticare che gustare i giorni e le ore è la cosa fondamentale che ti insegnano Dio e il prossimo. Questo la liturgia dovrebbe dirlo non come comandamento, ma come esperienza, come un'esperienza fontale e sorgiva della comunione con il Signore, del suo essere in mezzo ai suoi, nell'accompagnarli nell'atto del lodare, benedire, rendere grazie.
Lodare, benedire e rendere grazie è quanto di più profondamente umano esiste, ma anche qualcosa di cui l'uomo può facilmente dimenticarsi. Nel libro capolavoro di Beauchamp, Salmi notte e giorno, l'autore dice: nel rendere grazie noi riconosciamo che i nostri beni li dobbiamo agli altri e quindi in qualche modo usciamo da noi nel senso di riconoscere che la fonte del nostro bene è l'altro. Ma il lodare è ancora più importante e difficile, perché è rallegrarsi dei beni altrui. Lodare è un termine che non usiamo più nel linguaggio comune, se non a scuola (dieci e lode), o in chiesa. Normalmente non diciamo: "ti lodo molto per come mi hai trattato...", ma semmai: "faccio i complimenti, mi congratulo...". Nel fare i complimenti e nel congratularsi avvertiamo però il rischio dell'invidia, della gelosia. Nel lodare invece facciamo esperienza dell'atteggiamento tipico della preghiera per cui il bene dell'altro aumenta il bene mio. Lodare e rendere grazie dicono comunione e la liturgia è fatta di lode e di rendimento di grazie...
In sintesi, nella liturgia il tempo è reversibile e disomogeneo, perdona il passato e promette il futuro, nell'attesa dell'origine e nel ricordo della fine (in Avvento si celebra la fine, a Pasqua, nella Veglia ci si muove incontro al Risorto che ritorna facendo memoria della fede con Abramo, della liberazione con Mosé...)
d. nella liturgia scopro chi sono e faccio esperienza di fede
L'esperienza della fede ha a che fare con l'azione liturgica, la quale non è solo espressione della fede. Nell'esperienza della fede, e dunque nell'apertura alla rivelazione che Dio fa di sé, c'è inscritta una logica rituale che la tradizione della chiesa ha attraverso i tempi mantenuto. Per salvaguardare un'origine non disponibile, un'apertura radicale alla rivelazione, la fede ha bisogno di una particolare forma di esperienza, di linguaggio, di azione che è propria della liturgia. La liturgia è un'esperienza religiosa (si fa un'esperienza ma si è passivi), dove si parla un linguaggio che dice delle cose (ma che, mediate da queste, ne dice anche altre), dove si fanno azioni non soltanto per il futuro ma anche in rapporto al passato. L'azione rituale, il linguaggio simbolico e l'esperienza religiosa sono esperienze limite, linguaggi limite, azioni limite. Per questo sostenevo che, per entrare davvero nella liturgia della parola, non basta essere competenti di Scrittura. Certo, una certa competenza della Scrittura è necessaria, ma non è sufficiente. Chi vuole non soltanto conoscere un buon testo, ma incontrare il suo Signore, deve essere un po' animale, un po' bambino, un po' primitivo, un po' pazzo, cioè deve attingere a tutto quello che noi abbiamo dentro.
Come donne e uomini adulti, se non vogliamo essere dei manichini irrigiditi dobbiamo essere capaci di fare i conti con l'animale, il primitivo, il bambino, il pazzo che in noi rimane a nostra benedizione. Certo è quello che potrebbe farci correre in autostrada a 300 all'ora, ma è anche quello che ci fa arrossire, mentre l'uomo adulto vorrebbe solo mentire. L'uomo adulto si progetta per la menzogna, mentre l'animale che è in lui gli fa imporporare le guance... Questa è la delicatissima struttura dell'uomo come animale razionale, animale che ha la parola. Tra l'animale e la mente ci sono vari gradi di logiche un po' pazze come quelle della costruzione della liturgia della parola. Le liturgie della parola non sono costruite da teologi, ma sono costruite dalla tradizione in cui parlano narrazioni, associazioni di idee... Ci sono liturgie della parola costruite sul vento, sulla chiave, sull'acqua... E' la forza delle tradizioni simbolico-allegoriche, di poter diventare estremamente semplici, in cui la semplicità non è banalità, ma ricchezza.
4. Conclusioni sulla Chiesa
Quanto detto consente di trarre delle conclusioni interessanti che riguardano la chiesa. Che cosa è la chiesa? Proviamo a rispondere a questa domanda sulla base di quanto abbiamo ascoltato e lo facciamo ragionando sulla frequenza dell'azione simbolico-rituale, che istituendo comunione nel tempo donato, trova il proprio principio e fine nel Dio di misericordia e di amore. Proviamo a tradurre questa visione nelle categorie della "accoglienza" e della "sequela".
Celebrare riti, essere dentro una logica rituale significa rendere compatibile accoglienza e sequela, oltre i due modelli opposti che oggi frequentiamo abbastanza facilmente, a volte anche senza accorgerci, di una chiesa assolutamente accogliente, che non chiede sequela, o di una chiesa-setta, dove vige solo sequela senza accoglienza.
la Chiesa non è un'agenzia di servizi religiosi
La Chiesa non è anzitutto una agenzia di servizi religiosi, capace di offrire pacchetti di prodotti straordinari, ma senza chiedere nulla se non il fare la richiesta. Basta compilare il modulo per ricevere il pacchetto completo. Oggi c'è chi si sforza perché la Chiesa sia sempre di più questo, un'azienda di prodotti religiosi, senza nessuna richiesta di sequela, di discepolato, di formazione. E' un modello clericale di Chiesa, in cui gli unici formati sono i membri del clero, preti e vescovi. Nella Chiesa non c'è un servizio di qualcuno a qualcun altro, ma una serie di ministeri diversi e articolati, perché soggetto della storia sia Cristo in rapporto alla sua Chiesa, perché l'avvento del Regno innervi di sé la trama della storia.
la Chiesa non è una setta
Ma la chiesa non è neppure una setta integralista, dove vige solo la sequela senza accoglienza, dove tutti sono discepoli in senso forte, dove si entra solo dopo anni di studio e di formazione. E' un modello oppositivo di Chiesa, in cui tutti i membri sono di fatto separati dal mondo e sottoposti ad una omologazione forte. In questo caso il Regno si identifica con una Chiesa strutturalmente in conflitto con il mondo, che pretende di costruire una storia alternativa e separata.
L'accento posto solo sulla formazione e sul discepolato può condurre, ad esempio, a richiedere un tempo lunghissimo di preparazione al sacramento del matrimonio, per sposarsi veramente, per essere veramente discepoli di Cristo. Se la chiesa dovesse sostenere questo tradirebbe non solo il vangelo, ma anche la tradizione che afferma che è già sacramento lo sposarsi civilmente di un uomo e di una donna. San Tommaso, nel mettere in parallelo la vita naturale e la vita spirituale, sostiene che si nasce e si è battezzati, si cresce e si è cresimati, si mangia e c'è l'eucaristia, si cade in errore e c'è la penitenza, si diventa malati e c'è l'unzione degli infermi, si esercita il potere e c'è l'ordine, si genera e quello è il matrimonio. Il matrimonio è il sacramento più potente nel dire il legame inscindibile tra fede e natura, tra grazia e natura, ed è quello che più facilmente entra in crisi. Per questo alcuni teologi, come il maestro di san Tommaso, dicono che è un grande segno ma senza efficacia. E' paradossale, ma in qualche modo tutto questo intercetta il nostro balbettare intorno alla famiglia di oggi, in cui sembra che la grande battaglia per la Chiesa sia tra famiglia di fatto e famiglia di diritto. Per la chiesa la grande battaglia, se c'è battaglia, riguarda la famiglia di mistero, rispetto a cui fatto e diritto hanno una certa diversità di affidabilità, ma sono luoghi di salvezza e di peccato in modo indistinto. Ci sono famiglie di fatto con grandi esperienze genitoriali e famiglie di diritto con grande ipocrisia. E' fondamentale ricordarsi che la chiesa ha sempre assunto il fatto della "fuitina" come matrimonio. Quando due minorenni, i cui genitori sono contrari alla loro intenzione di sposarsi, scappano e si uniscono, la chiesa riconosce il loro matrimonio e non il giudizio dei genitori. Questo è il primato del fatto sul diritto di fronte alla logica del sacramento. Questo è ciò che riceviamo dalla tradizione, ma sembra oggi impossibile dirlo, perché rimaniamo nella logica solo pubblica o privata, e non riusciamo ad accedere a una logica comunitaria e intersoggettiva.
Chiesa come comunità di accoglienza nel discepolato e comunità di discepolato accogliente
La Chiesa non è una setta, né agenzia di servizi, ma una comunità di accoglienza nel discepolato e una comunità di discepolato accogliente. Cioè è una comunità che accoglie radicalmente indicando un percorso di formazione, di ascolto, di azioni rituali, di aiuto al prossimo, di autentico discepolato, e viceversa, una comunità di discepolato che non si chiude, che rimane aperta ed accogliente. Ci sono tante esperienze di autentico discepolato cristiano, che però diventa inautentico quando diventa principio di chiusura. Se dopo aver trovato Gesù Cristo, la prima cosa che faccio è quello di chiudere la porta in faccia a qualcuno, sono inautentico. Se dico che, dal prossimo anno, la veglia pasquale la facciamo da soli, assumo un atteggiamento contraddittorio che mette in gioco la fede. Al centro non è più Gesù Cristo, ma uno dei tanti idoli che servono per farci gli affari nostri. Se è Gesù Cristo, i muri sono abbattuti. Se i muri si innalzano vuol dire che non è lui. Lì dove la chiesa incontra davvero Cristo - quando è un'agenzia che offre servizi non ha bisogno di muri ma solo di sportelli - ci sono muri trasparenti, fragili, ci sono distinzioni trasgredibili continuamente che sono la differenza tra pubblico e privato in una comunità. Celebrare non può essere semplicemente qualche cosa di pubblico e di privato, ma deve trovare lo spazio di una comunità, che per identificarsi segna il territorio. Segnare il territorio non significa innalzare i muri, ma introdurre una parola di trasgressione previa e ulteriore rispetto a tutto quello che si dice necessariamente in privato e in pubblico. Questo credo che sia il punto nel quale le quattro cose da ricordare e le quattro da dimenticare si uniscono in una esperienza ecclesiale, alla luce del celebrare.
Il modello di questa chiesa del discepolato accogliente e della accoglienza per il discepolato è un modello di comunione, che scaturisce da quattro azioni elementari, fondamentali, quattro accessi al mistero di Dio in Cristo: la celebrazione della liturgia, l'ascolto della parola, la relazione testimoniale ecclesiale, la relazione profetica con il mondo che corrispondono alle quattro costituzioni del Vaticano II.
All'origine e alla fine della Chiesa - come esperienza dell'incontro di grazia con il Risorto - non c'è una dottrina, né una norma, ma un rito, che permette alle generazioni di incontrare il mistero di Dio, rivelato nel Figlio e comunicato nello Spirito. Solo il rito, con il suo agire simbolico, sa tenere insieme Dio e l'uomo, Cristo e la Chiesa, l'eterno e il tempo, la memoria e l'oblio, "ciò che non muore e ciò che può morire" (Dante Alighieri).
Non so in che misura questo sia diventato più chiaro dopo le parole che vi ho detto. Per me questo è diventato un modo di interpretare la chiesa, un modo di interpretare la rivelazione e la fede e anche un modo di interpretare la laicità. In fondo l'atto rituale cristiano ha bisogno di ricuperare un concetto autentico di laicità che non si lasci includere né dagli idoli del tradizionalismo, né dagli idoli del liberalismo senza iniziazione. Un tradizionalismo solo iniziatico o un liberalismo senza iniziazione non sono veramente laici. Sono fughe dalla laicità. La laicità è non indifferenza. La laicità maturata come indifferenza è la cosa peggiore. Ma la non indifferenza nella chiesa deriva anzitutto dal lasciarsi attraversare da una parola più alta, da un'azione più alta, come è la tradizione biblica e la tradizione liturgica.
un breve riassunto
La riscoperta della liturgia è possibile solo se rinunciamo ad un certo intellettualismo che ha dominato per secoli e in maniera crescente la chiesa. La liturgia è strutturalmente trasgressiva. È trasgressiva per come usa la parola, il canto, le vesti, il profumo. È trasgressiva perché rinvia ad un fondamento non dominabile e controllabile: il Signore Gesù, presente come origine di tutto quello che la Chiesa è.
Non è più chiaro oggi quanto sia diverso il messale di Paolo VI (quello della riforma conciliare) da quelli precedenti. La diversità non significa discontinuità assoluta, ma riforma, vale a dire discontinuità a servizio della continuità.
Le quattro costituzioni conciliari non aggiungono dogmi e non condannano nessuno. La Chiesa deve ricominciare dal suo punto di partenza, che non è il dogma, il canone o la proposizione morale, ma l'ascolto della Parola (Dei Verbum) la celebrazione del culto (Sacrosanctum Concilium), la relazione testimoniale ecclesiale (Lumen Gentium), il rapporto profetico col mondo (Gaudium et Spes). Il dogma è al servizio dell'ascolto della Parola e della celebrazione eucaristica e non il contrario. Se non recuperiamo questo livello, ci dice il Vaticano II, tutto è perduto: ripeteremo i dogmi, ma senza esperienza ecclesiale.
L'esperienza cristiana che facciamo nella liturgia, segnata dalla centralità della Parola, segnata dall'incontro profondo con il Signore, è un'esperienza che non possiamo fare se non ci riconciliamo con la nostra dimensione animale, infantile, primitiva e pazza (Merleau-Ponty). Facciamo una enorme fatica a cogliere il linguaggio simbolico, rituale della liturgia, schiavi di una visione intellettualistica. Ci vorranno alcune generazioni perché la riforma liturgica vada a regime, perché il Vaticano II sia vissuto come una forma canonica. Per contrastare che questo avvenga gli si mette vicino la forma canonica precedente (il messale di Pio V accanto al messale di Paolo VI), che tende ad essere percepita come più autorevole
Profilo storico della liturgia
La questione liturgica nasce a primi dell'Ottocento. Tutte le forme rituali entrano in crisi, anche nella Chiesa.
Il movimento liturgico nasce agli inizi del 1900 per far fronte a questa crisi. In una prima fase si incomincia a dire che nella liturgia c'è qualcosa di originario per la fede: non solo si esprime la fede che si ha, ma si fa esperienza di una fede. Nel momento liturgico Dio si rivela e l'uomo crede. Le posizioni del movimento liturgico sono accolte solo parzialmente da Pio XII nella Mediator Dei del 1947, che manterrà pratiche incompatibili con le istanze di rinnovamento. Si crea così un doppio regime, quello dei liturgisti e delle parrocchie liturgiste e quello dei devozionalisti e delle parrocchie devozionaliste che convivono fino al Concilio.
Intensa e vasta comunque è stata l'opera di elaborazione fino al 1947. Si riscopre la presenza del Signore nella Parola, nell'assemblea, nella ministerialità, oltre che nel pane e nel vino. Questa nuova prospettiva, che sarà accolta dal concilio (la Sacrosanctum Concilium parla di presenza reale nella Parola), implica non solo un cambiamento di dottrina, ma un cambiamento di esperienza.
Per risolvere la questione liturgica si punta quasi esclusivamente alla riforma dei riti, nel periodo che va da Pio X a Giovanni Paolo II. Tutti i riti vengono riformati, nel corso di 40 anni, introducendo una liturgia della Parola in tutti i riti, utilizzando le lingue nazionali.
Con la riforma dei riti, però, il compito non è finito. Non basta modificare i riti, è necessario modificare gli atteggiamenti con i quali ci rapportiamo ai riti. Bisogna lasciare che i riti riformati diano forma alla Chiesa, in tutti i sensi, anche dal punto di vista architettonico (le chiese non sono dei musei, ma luoghi di vita). Questo significa dar loro la parola a tutti i livelli, a livello dei muri, del tempo, della sensibilità, dei gesti, delle parole...
Questo ripensamento della liturgia ha anche un risvolto importante sul piano teorico, e cioè nel modo di intendere la forma, la materia e il ministro dei sacramenti. Con la riscoperta della centralità della Parola scopriamo che la forma dell'eucaristia non è solo la formula (di consacrazione), ma tutte le parole che vengono dette e ascoltate, che la materia non è solo il pane e il vino, ma il pane e il vino dentro una serie di relazioni (pane spezzato, mangiato...), che il ministro non è più unico, ma plurale. Le tante parole, i movimenti del pane e vino, hanno molti soggetti durante la celebrazione.
Il movimento liturgico porta poi alla luce che la forma del rito non comprende solo tutte le parole che si dicono, ma tutti i linguaggi che si usano, come quello dello spazio, del tempo, della vicinanza, del colore, del profumo, della musica, del canto, del silenzio, dello sguardo, del tatto, dell'olfatto. In questi linguaggi è coinvolta la nostra dimensione animale, infantile, primitiva, pazza oltre che adulta. La ministerialità diventa una sola presidenza che coordina tante ministerialità, a servizio di Cristo e della Chiesa.
I soggetti della Eucaristia sono Cristo e la Chiesa, mentre tutti gli altri sono servi.
Quattro cose da non dimenticare / quattro da dimenticare
Si comprende meglio quello che si deve ricordare se per contrasto si individua ciò che si deve dimenticare.
Innanzitutto bisogna ricordare che la liturgia è un'azione rituale, e cioè che non è solo esercizio di un diritto o di un dovere. Tutte le discussioni attorno al funerale di Welby parlavano di diritti e di doveri, trascurando che un'azione liturgica è anzitutto esperienza ecclesiale, principio di ogni diritto e dovere.
La liturgia è inoltre un'esperienza comunitaria: non è un'esperienza privata e non è un'esperienza pubblica. Il concilio parla di partecipazione attiva di tutti all'unico rito, di piena comprensione dei riti e delle preghiere. Per consentire questa partecipazione è necessario che i riti siano accessibili: ecco il perché della introduzione delle lingue nazionali.
La liturgia non è però un'esperienza pubblica. Fare comunità vuol dire non essere soli con se stessi di fronte al buon Dio, ma neanche sotto l'occhio neutro del pubblico. Un sacramento non sarà mai un fatto semplicemente pubblico, ma sarà sempre un fatto comunitario. Il luogo pubblico come tale non garantisce quel minimo di separatezza richiesta dall'azione liturgica e dal suo linguaggio inevitabilmente iniziatico, non comune.
La liturgia poi è un tempo festivo: non è né il tempo libero, né il tempo del lavoro. La liturgia fa fare un'esperienza del tempo diversa da quella comune, quella del tempo come dono, del tempo che mi è donato come un'esperienza gratuita da parte di Dio e del prossimo. Il tempo festivo mi dice che posso godere del tempo perché qualcun altro mi è stato accanto e ha perso tempo con me. Il tempo festivo è il tempo gratuito.
La liturgia infine è fonte e culmine, e non un mezzo o uno strumento per far passare qualche messaggio o qualsiasi altra cosa.
conseguenze di queste affermazioni e negazioni (nel corpo)
Quanto detto ha conseguenze anzitutto nel corpo. Ci preoccupiamo di pronunciare parole corrette, di compiere i gesti previsti, ma prestiamo poca attenzione al tatto, al fondamento di ogni senso. Quando le persone sono distanti quindici metri l'una dall'altra durante la celebrazione il tatto percepisce la dissonanza con il fare comunità.
1. Se la liturgia è un'azione rituale tutti partecipano a un'unica azione di Cristo e della Chiesa. Questo vuol dire che i veri soggetti non sono titolari di diritti e di doveri ma destinatari di azioni, parole, canti, silenzi, avvicinamenti, allontanamenti. Tutte le logiche puramente oggettive e soggettive restano sullo sfondo e viene in primo piano una logica intersoggettiva, comunitaria. E' una logica che stenta ad affermarsi. Il fare la comunione nella maggioranza dei casi si limita a ricevere la particola e non si esprime nel partecipare insieme al pane spezzato e al calice condiviso. Ma anche nel caso della comunione "sotto le due specie" il bere allo stesso calice è sostituito dall'intingere, sminuendo il gesto che dice fraternità e figliolanza.
2. Che nella messa non si sia né in pubblico, né in privato, lo possiamo dire in tanti modi. Ma anzitutto lo diciamo perché non ci sentiamo né a un tu per tu con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito Santo né in pubblico di fronte agli altri. Questo comporta un cambiamento nella catechesi. Fare la prima comunione non è anzitutto avere un rapporto a tu per tu con Gesù. Viene trascurata la dimensione comunitaria, ecclesiale, il sentirsi riconosciuti, sotto lo sguardo accogliente e nello sguardo riconoscente del Padre e dei fratelli.
3. Nella messa il tempo non è quello scandito dall'orologio, non è il tempo omogeneo e irreversibile. Il tempo del rito è disomogeno e reversibile, non è tutto uguale e non va in una sola direzione, riempiendosi di differenze. La mia coscienza del tempo dipende da come Dio e il prossimo si sono presi cura di me. Gustare i giorni e le ore è la cosa fondamentale che ti insegnano Dio e il prossimo. Questo la liturgia dovrebbe dirlo non come comandamento, ma come esperienza, come un'esperienza fontale e sorgiva della comunione con il Signore, del suo essere in mezzo ai suoi, nell'accompagnarli nell'atto del lodare, benedire, rendere grazie.
4. Nella messa l'azione liturgica mi fa scoprire chi sono non solo esprimendo ciò che già so. La messa è esperienza di fede, non solo espressione di essa. Per salvaguardare un'origine non disponibile, un'apertura radicale alla rivelazione, la fede ha bisogno di una particolare forma di esperienza, di linguaggio, di azione che è proprio della liturgia.
conclusioni sulla Chiesa
Quanto detto ha delle ripercussioni sul modo di concepire la chiesa.
La Chiesa non è una setta, né agenzia di servizi, ma una comunità di accoglienza nel discepolato e una comunità di discepolato accogliente. Cioè è una comunità che accoglie radicalmente indicando un percorso di formazione, di ascolto, di azioni rituali, di aiuto al prossimo, di autentico discepolato, e viceversa, una comunità di discepolato che non si chiude, che rimane aperta ed accogliente. Il modello di questa chiesa del discepolato accogliente e della accoglienza per il discepolato è un modello di comunione, che scaturisce da quattro azioni elementari, fondamentali, quattro accessi al mistero di Dio in Cristo: la celebrazione della liturgia, l'ascolto della parola, la relazione testimoniale ecclesiale, la relazione profetica con il mondo che corrispondono alle quattro costituzioni del Vaticano II.
Il testo delle relazioni, tenute a Pallanza il giorno 19 gennaio 2008 da Andrea Grillo, non è stato revisionato dal relatore
